Difficile immaginare un’occasione di incontro e confronto più seducente, un evento in grado di coniugare in modo così mirabile fascino e sostanza. Un palazzo storico – tra le residenze più “iconiche” della città – con terrazza affacciata sull’Arno, cultori del bello da ogni parte del mondo, fuochi d’artificio inaugurali e ritrovi mondani; e al centro di tutto, uno straordinario patrimonio di dipinti, sculture, arredi, ceramiche, gioielli e reperti romani, etruschi e medievali: «Come un museo, però in vendita», per riprendere la definizione coniata da Fabrizio Moretti, che della Biennale Internazionale di Antiquariato di Firenze è Segretario generale dal 2014. Punto di riferimento per il collezionismo internazionale, capace di catturare l’attenzione dei migliori mercanti d’arte sulla piazza, la nuova edizione della Biaf – la numero 33, in calendario dal 28 settembre al 6 ottobre – è alle porte; si attende l’arrivo delle 80 gallerie partecipanti, fervono i preparativi: «Per la cena di gala ho difficoltà a rispondere a tutte le richieste, dobbiamo gestire un overbooking pazzesco», ci racconta Moretti – con una punta di entusiasmo trattenuto – quando lo raggiungiamo al telefono. La serata – con spettacolo pirotecnico finale – si terrà giovedì 26 alla presenza di 780 ospiti che si accomoderanno lungo le sale di Palazzo Corsini, epicentro della kermesse espositiva; la “regia” culinaria – come due anni fa – è affidata alla Gucci Osteria di Massimo Bottura. Altrettanto esclusiva sarà la cena in programma il giorno dopo, il 27, questa volta nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, teatro dell’evento charity a favore della Fondazione Andrea Bocelli, dove si avrà modo di assistere a una performance canora del Maestro e di partecipare all’asta di beneficenza – orchestrata dal celebre battitore Simon de Pury – in favore dei progetti sostenuti ad Haiti dalla stessa fondazione.

Dal punto di vista del glamour, sono i momenti clou di una manifestazione che si sviluppa comunque da una radice identitaria ben definita, si premura di specificare il Segretario generale: «La Biennale è sia luogo di scambi commerciali sia appuntamento di grande livello intellettuale, e come tale genera mondanità, che è sempre conseguenza del bello, dell’elegante, del raffinato». Della capacità attrattiva della Biaf, sintetizza Moretti, è testimonianza l’album fotografico delle sue edizioni, affollato di collezionisti, appassionati, esponenti dell’ambiente culturale e del gotha dell’imprenditoria, stelle del cinema e altre celebrità. È una storia che inizia nel 1953, quando Luigi Bellini ebbe l’illuminata intuizione di radunare nella propria città il meglio dell’antiquariato italiano. Sei anni più tardi, nel 1959, i figli Mario e Giuseppe – coadiuvati dai membri dell’Associazione Antiquari d’Italia, nata appositamente in quell’anno – dettero vita, nella maestosità rinascimentale di Palazzo Strozzi, alla più importante manifestazione del genere nel nostro Paese, con il coinvolgimento di quell’élite di stranieri in grado di cogliere il senso valoriale profondo di una città come Firenze, che ha visto da sempre intrecciare le sue vicende artistiche con quelle del collezionismo privato, e quindi dell’investimento nell’arte: una vocazione, quest’ultima, ininterrotta anche nell’Ottocento e nel Novecento, quando le grandi famiglie borghesi e industriali hanno proseguito nel solco di questa tradizione ideale, raccogliendo e investendo in bellezza e cultura.

Oggi la Biennale è considerata la mostra-mercato più importante al mondo per l’arte antica italiana, invitando un gruppo selezionato di antiquari capace di proporre un ampio ventaglio di opere garantite da un autorevole vetting. Certo, non sono più gli Anni Sessanta, quando i giorni della rassegna erano il periodo più eclatante della vita mondana italiana. In confronto a quella atmosfera raffinatissima, «il lusso sparato di Art Basel e di Tefaf si riduce a un accumulo d’aerei privati e di cenette chiassose», ricordava un paio di anni fa un articolo di Bruno Muheim pubblicato da Il Giornale dell’Arte. «Tutti i grandi patrimoni tedeschi, olandesi, inglesi, svizzeri o francesi erano presenti. L’aristocrazia fiorentina riceveva in modo sublime nelle sue regge, le case di moda di Firenze come quella di Emilio Pucci erano affollatissime». Per dire: la mostra del 1961 fu una formidabile vetrina del mondo dello spettacolo dell’epoca, con presenze quali Josephine Baker, Greta Garbo, Sofia Loren, John Huston, l’altera Silvana Mangano accompagnata da Mauro Bolognini, Paulette Goddard con Erich Maria Remarque, tutti testimoni di quel mondo raffinato che una volta si usava definire “jet-set”.
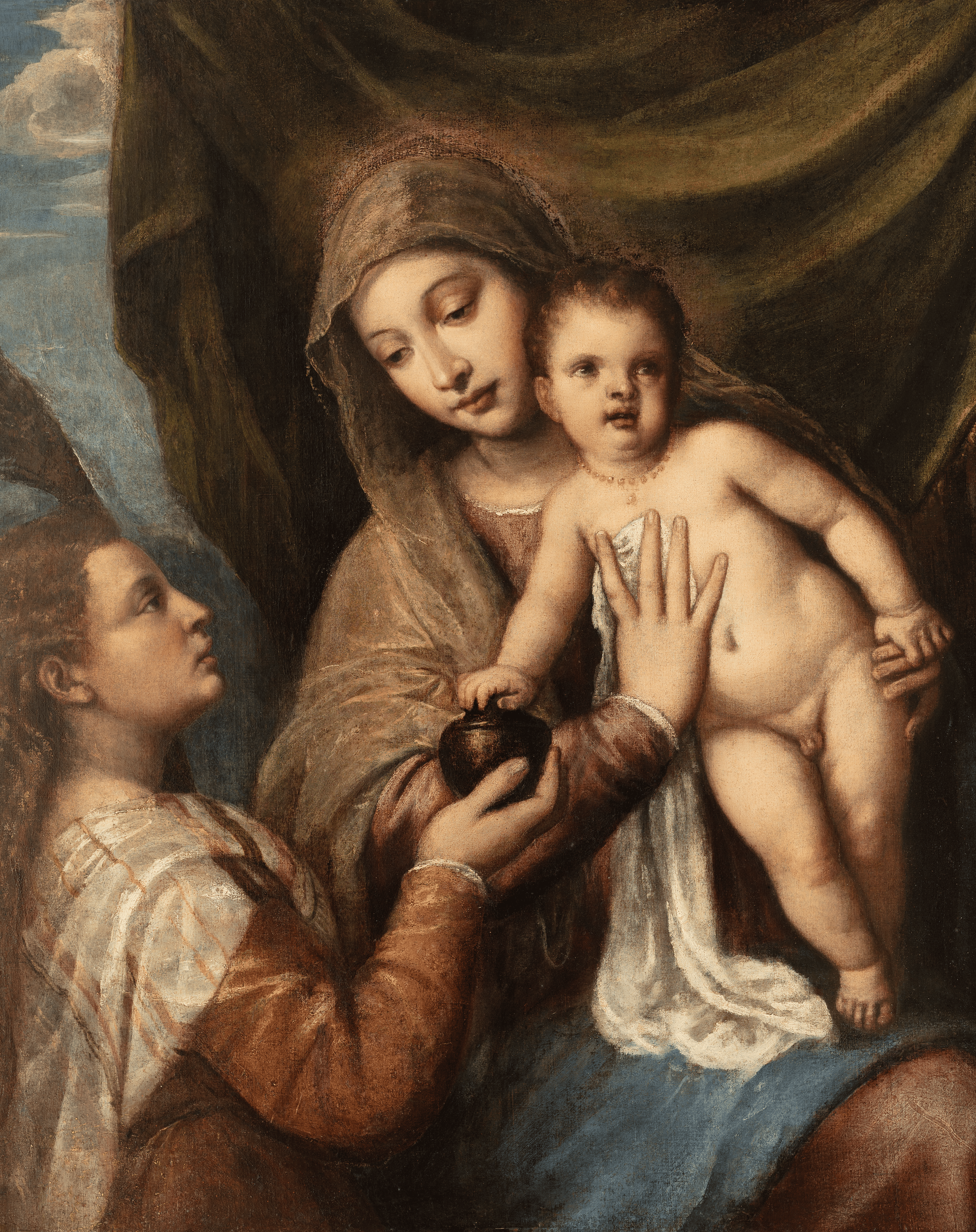
I tempi cambiano, si diceva; eppure, va dato merito alla gestione Moretti di aver riportato sulla manifestazione la luce dei riflettori anche da un punto di vista dell’immagine, ovvero «di aver rinfrescato la curiosità, perché la Biennale è sempre stata una grande mostra», si schermisce lui, che ha respirato queste atmosfere sin da ragazzino: «Erano gli anni Ottanta e la Biennale mi incuteva un timore reverenziale; quando andavo a trovare mio padre che esponeva mi pareva di entrare in un mondo di onnipotenti, di intoccabili, un mondo che quasi mi faceva paura». Diventato adulto e giunto – guarda il caso – sul ponte del comando, il Segretario si è adoperato per avvicinare una nuova audience, di estendere nella misura del possibile i confini di un mercato che è sì sofisticato e di nicchia, ma che cela al contempo potenzialità da esplorare: da qui l’interesse per le generazioni più giovani, da qui – per esempio – gli inviti rivolti in passato a stelle dell’arte contemporanea come Urs Fisher e Jeff Koons, chiamato a inaugurare l’edizione 2015. Oggi il pubblico è senz’altro più variegato, a conferma che «noi siamo aperti a tutti», e che la Biennale è molto meno snob di quanto si possa pensare.

Location d’eccezione – si accennava all’inizio –, il sontuoso Palazzo Corsini, sede della Biaf dal 1997, in un allestimento rivisto dall’interior designer, scenografo e regista Matteo Corvino, con il Salone del Trono al piano nobile che Gucci – quest’anno anche main sponsor dell’esposizione – trasforma per l’occasione in un “salotto” dove i visitatori possono scambiarsi opinioni ed emozioni. Un’atmosfera che si riverbera anche al di là di queste storiche mura, connettendosi con il palinsesto dell’annuale e concomitante Florence Art Week, la settimana dedicata all’arte in tutte le sue forme che contempla anche le attività e gli eventi proposte ai possessori della Vip Card dalle maison di moda di Via Tornabuoni, dalle gallerie di Via Maggio, Via de Fossi e Borgognissanti, e dalle boutique di Ponte Vecchio. «L’arte è fruibile a tutti, e il nostro evento vuole essere un invito a scoprirla e ad amarla. Un’operazione di sensibilizzazione necessaria, in questa epoca di pochezza culturale», conclude Moretti.
1 Ottobre 2024


